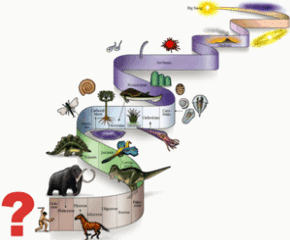 VENEZIA, 13 settembre 2006. - Le scimmie le abbiamo accettate: sono le nostre bis-biscugine. E quindi siamo scimmie nude, con volti e corpi ingentiliti. Ecco perché adesso lo sguardo salta al futuro: come saremo tra mille anni? E tra 10 mila? L’evoluzione ci sta ancora plasmando o si è interrotta? Gli scienziati e anche i non scienziati hanno cominciato a farsi domande appassionanti, degne dei sogni e degli incubi più folli, a cui forse non è estranea l’influenza di qualche gene che si preoccupa di proiettarsi nelle ere più lontane. Quelle domande e le prime e conturbanti risposte si sentiranno a Venezia, alla «Conferenza Mondiale sul Futuro della Scienza» promossa dal 20 al 23 settembre dalla Fondazione Veronesi.
VENEZIA, 13 settembre 2006. - Le scimmie le abbiamo accettate: sono le nostre bis-biscugine. E quindi siamo scimmie nude, con volti e corpi ingentiliti. Ecco perché adesso lo sguardo salta al futuro: come saremo tra mille anni? E tra 10 mila? L’evoluzione ci sta ancora plasmando o si è interrotta? Gli scienziati e anche i non scienziati hanno cominciato a farsi domande appassionanti, degne dei sogni e degli incubi più folli, a cui forse non è estranea l’influenza di qualche gene che si preoccupa di proiettarsi nelle ere più lontane. Quelle domande e le prime e conturbanti risposte si sentiranno a Venezia, alla «Conferenza Mondiale sul Futuro della Scienza» promossa dal 20 al 23 settembre dalla Fondazione Veronesi.
Professor Telmo Pievani, lei è docente di filosofia della scienza all’università di Milano-Bicocca e uno degli organizzatori del summit che raccoglie i nomi celebri dell’evoluzionismo. Come immagina noi sapiens tra 10 secoli? Meglio o peggio di adesso?
«Meglio o peggio è difficile a dirsi. Immagino - con una battuta - che perderemo in prestanza fisica, mentre svilupperemo ulteriormente le capacità culturali e tecnologiche».
Diventeremo più intelligenti?
«Il cervello è un sistema ridondante, come il genoma: contiene molte più cose di quelle che apparentemente servono. La biologia fissa le potenzialità, che possono essere sfruttate in direzioni diverse, secondo il concetto di plasticità. Quindi - come dice Richard Dawkins - i geni non sono il fato, ma ricette: tocca allo sviluppo e all’ambiente fare una torta buona o cattiva. Alcune proiezioni sostengono che le capacità cerebrali siano destinate ad aumentare progressivamente, anche se non è detto che si tratti di capacità cranica».
In che senso?
«E’ impressionante che non solo i nostri cugini Neanderthal ma anche i primi Cro-Magnon avessero una capacità cranica leggermente superiore alla nostra: quindi, per noi, evoluzione potrebbe significare qualità invece di quantità».
E qui si apre la grande questione: se alcuni (Bruce Lahn della University of Chicago) sostengono che ci evolviamo ancora, altri (Steve Jones dello University College London) ribattono che la nostra sopravvivenza non dipende più dalle mutazioni del DNA. Dove sta la verità più probabile?
«Sono due correnti di pensiero. La prima ritiene che l’homo sapiens si sia sempre evoluto con gradualità e che il processo continui, piano piano, anche oggi. La seconda pensa che intorno a 50 mila anni fa sia avvenuta un’accelerazione evolutiva, preceduta e seguita da lunghe fasi di stabilità, e la deduce dal fatto che nel Paleolitico l’homo sapiens ha iniziato a fare cose strane e avanzate, come dipingere caverne, costruire calendari, fabbricare oggetti rituali. Il “grande balzo in avanti” - vale a dire la rivoluzione cognitiva - sarebbe avvenuto allora e da quelmomento saremmo diventati “moderni”. Si tratta, in realtà, di conclusioni solo in apparenza contraddittorie. L’evoluzione a livello molecolare agisce incessantemente, ma poi bisogna capire se e come si traduce in nuovi tratti adattativi visibili. Noi siamo una specie bambina, con non più di 200 mila anni alle spalle, e ci osserviamo con la scansione ravvicinata delle generazioni. E infatti i biologi molecolari non percepiscono che piccole e superficiali mutazioni, legate per esempio all’aspetto esteriore delle popolazioni umane o alla predisposizione a determinate malattie».
Si è capita la logica dell’intreccio? E’ sempre l’evoluzione genetica a determinare quella culturale o c’è un rapporto di reciprocità?
«E’ il problema che affronterà Luigi Luca Cavalli Sforza e dal suo intervento emergerà uno spostamento di prospettiva. In passato si quantificavano le determinanti genetiche rispetto a quelle culturali con rapporti percentuali,tipo 80-20. Oggi si parla di un gioco di intrecci: il corredo genetico influenza profondamente il comportamento umano, ma l’evoluzione culturale è diventata tanto potente da modificare a sua volta il nostro patrimonio genetico. Un esempio è l’invenzione dell’agricoltura: trasformando le specie vegetali e animali, abbiamo cambiato l’ambiente in cui siamo immersi e con quello ci siamo coevoluti. Se invece passiamo a previsioni di lungo termine, pur sempre molto speculative, il quadro muta ancora».
In che modo?
«Come racconterà Ian Tattersall i fattori evolutivi classici che agiscono sulle altre specie si sono indeboliti nella specie umana: non c’è isolamento geografico, dato che siamo cosmopoliti e invasivi, e ci sono la medicina, l’igiene e l’assistenza a contrastare gli effetti della selezione naturale. Sempre di più l’evoluzione dell’uomo sarà un processo autoindotto, mediato dalla tecnologia e dalla cultura, ma non per questo meno naturale. L’evoluzione è un processo continuo che ci lega con un filo ininterrotto al resto del vivente, ma che produce anche novità eclatanti. Siamo un “glorioso accidente”, come scriveva Stephen Jay Gould, e la nostra unicità cerebrale - sottolineerà Michael Gazzaniga - ha prodotto due fenomeni eccezionali, l’intelligenza cosciente e il linguaggio articolato, vero Santo Graal degli evoluzionisti.
Decifrare queste elusive proprietà che non lasciano fossili - spiegheranno tra gli altri Daniel Dennett, Steven Pinker, Marc Hauser e Antonio Damasio - è la nuova ed emozionante frontiera della ricerca: carpire il segreto adattativo di quel minuscolo 1,4% di differenza genetica che ci fa essere al contempo così vicini e così incredibilmente diversi dagli scimpanzé».
Da La Stampa Web
